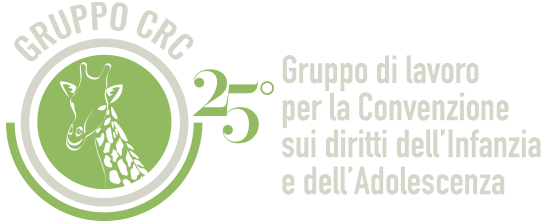In Italia, circa 1,7 milioni di giovani tra i 15 e i 29 anni non studiano, non lavorano e da oltre 6 mesi non seguono un percorso formativo. Nonostante il nostro paese sia il secondo nell’Ue con il più alto tasso di NEET (16,1%) – preceduto solo dalla Romania (19,8%) – rischiamo di dover restituire all’Europa circa 1 miliardo di euro per il mancato utilizzo delle risorse del Programma Operativo Nazionale – Iniziativa Occupazione Giovani. Erano infatti circa 2,7 miliardi di euro nel periodo 2014-2020 quelli messi a disposizione per l’Italia per reintegrare nel mondo del lavoro i giovani NEET. ActionAid e CGIL tornano a dare una fotografia dettagliata del fenomeno con il Rapporto “NEET: GIOVANI IN PAUSA. Superare gli stereotipi per costruire politiche pubbliche efficaci“, un’analisi non solo delle politiche pubbliche adottate fino ad ora per rispondervi, ma anche dei fondi stanziati per la loro realizzazione, con raccomandazioni per superare l’impatto di divari territoriali, disparità di genere e diseguaglianze sociali ed economiche che caratterizzano la realtà dei giovani in Italia.
FONDI NON SPESI. Per far fronte al forte aumento di giovani in condizione di NEET, a dicembre 2013, l’Unione europea ha promosso il primo intervento di politiche attive strutturato, Iniziativa occupazione Giovani (IOG). Finanziata nell’ambito della programmazione settennale 2014-2021, IOG è il principale strumento di attuazione del programma Garanzia Giovani, che in Italia prevede una dotazione finanziaria di circa 2,7 miliardi di euro. Secondo la Ragioneria generale dello Stato a febbraio 2024, i pagamenti certificati ammontavano a 1,6 miliardi, ovvero il 62% dei fondi stanziati. È doveroso però specificare che si tratta di dati che restituiscono un quadro provvisorio che, se confermato al termine della rendicontazione, richiederà all’Italia di restituire all’Unione europea circa 1 miliardo di euro, mancando l’opportunità di contrastare un fenomeno che si stima costi allo Stato italiano circa 25 miliardi l’anno, l’1,4% del PIL italiano.
HA FUNZIONATO GARANZIA GIOVANI? Dall’analisi di ActionAid e CGIL risulta che Garanzia Giovani ha contribuito a reintrodurre nel mercato del lavoro solo il 26% della popolazione NEET del nostro Paese. Il programma in circa dieci anni (2014-2023) ha coinvolto circa l’82% della popolazione giovanile residente in Italia in condizione NEET. Ad accedere al programma sono stati soprattutto uomini (52%) di età compresa tra i 19 e i 24 anni (56,2%) residenti nel Sud Italia e nelle Isole (43,4%). Di questi, il 47,6% ha completato il percorso intrapreso, ma solo il 32% a sei mesi dalla fine del programma risulta occupata/o. Una quota che comprende prevalentemente giovani in una condizione di maggiore privilegio – 58,8% di uomini del Nord ovest e in possesso di un titolo di laurea (61%) – rispetto a coetanee/i residenti nei territori del Sud o del Centro e con bassi livelli di istruzione.
DONNE, SEMPRE PIÙ SVANTAGGIATE. Sebbene nell’ultimo anno sia stata registrata una decrescita dell’incidenza delle e dei giovani NEET (-2,9%), la quota di giovani donne è aumentata di circa l’1% rispetto all’anno precedente arrivando a toccare il 59%, che aumenta nel caso delle giovani di origine straniera (73%). La quota di donne NEET è però rimasta sempre molto alta rispetto a quella degli uomini. Ad incidere su di essa contribuisce da sempre il lavoro di cura familiare che ricade soprattutto sulle loro spalle. Le ragazze rappresentano infatti la quota maggiore (65%) di NEET definiti inattivi, ma tra loro il 30% delle giovani dichiara di non essere alla ricerca di lavoro perché impegnata nella gestione dei carichi di cura familiari di minorenni o persone non autosufficienti e il 21% per altri motivi familiari (es. è casalinga).
DIVARI TERRITORIALI. Anche nel 2023, la maggiore incidenza di giovani NEET è stata registrata nel Sud e nelle Isole (28,4% contro il 11,7% del Nord). In Italia il luogo in cui si vive incide ancora profondamente sulle opportunità formative e lavorative delle e dei giovani. La Regione Sicilia ha il tasso di incidenza più alto (32,2%), seguita dalla Campania (31,2%) e dalla Calabria (30,3%).
Per consultare il Rapporto, clicca qui.