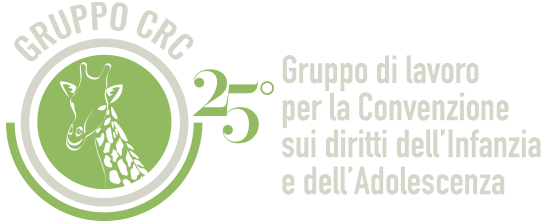La giustizia penale minorile rappresenta uno dei rari (e troppo poco raccontati) contesti giuridici in cui l’Italia si è attestata come esperienza pilota, studiata e copiata a livello europeo (basti pensare che la Direttiva UE 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minorenni indagati o imputati nei procedimenti penali prende come modello proprio il sistema procedurale italiano).
Alla base del sistema minorile italiano, infatti, si pongono il principio penologico della funzione educativa (e non dunque genericamente rieducativa) della pena, il principio personalistico (con i corollari della responsabilizzazione e autonomia del minore), e ancora i principi del carcere come (vera) extrema ratio in considerazione dei rischi di istituzionalizzazione ben noti alle discipline che si occupano di minorenni, del riconoscimento della dignità e personalità della persona di minore età, del primato dell’ascolto e al contempo della necessità della rappresentanza legale, della de-stigmatizzazione e della presa in carico sociale e specialistica, ove necessaria.
Nel tempo, la giustizia penale minorile nel quotidiano lavoro di iuris dicere e la Corte costituzionale in plurime pronunce hanno limato, valorizzato, costruito il senso di questi principi, condivisi nella pratica e nella coscienza giuridica del giudice minorile. In particolare, la Corte costituzionale ha operato una sorta di rivoluzione penologica del senso della giustizia penale in ambito minorile. Nella storica sentenza in cui dichiara l’illegittimità costituzionale dell’applicazione della pena dell’ergastolo alla persona minorenne imputabile, infatti, la Corte afferma che il paradigma della giustizia penale minorile in Italia è informato, a livello costituzionale, dalla valorizzazione dell’art. 31 della Costituzione, ossia dell’obbligo posto in capo allo Stato, di protezione dell’infanzia e della gioventù.
Letto, infatti, alla luce degli obblighi internazionali pattizi (e eminentemente alla luce dell’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che sancisce il principio dei best interests of the child), l’art. 31 Cost. impone “di diversificare il più possibile il trattamento del minore dalla disciplina punitiva generale”. Questa diversificazione, ci dice ancora la Corte costituzionale opera, da un lato, sul piano della polifunzionalità della pena: in ambito minorile, infatti, la funzione riabilitativa, di cui all’art. 27, comma 3 Cost., è da considerarsi, “se non esclusiva, certamente preminente”. D’altro lato, tale diversificazione vale a risignificare ciò che è riferibile alla generalità dei soggetti quanto alla funzione rieducativa della pena. Insomma, dice la Corte, il termine ‘rieducazione’ va inteso, nell’ambito della giustizia penale minorile, come un appello alla funzione di ‘cura educativa’: si “impone un mutamento di segno al principio rieducativo immanente alla pena, attribuendo a quest’ultima, proprio perché applicata nei confronti di un soggetto ancora in formazione e alla ricerca della propria identità, una connotazione educativa più che rieducativa, in funzione del suo inserimento maturo nel consorzio sociale”.
Questo scarto terminologico (dalla ri-educazione all’educazione) è la pietra angolare dell’intero sistema della giustizia penale minorile, così come della procedura penale minorile che proprio di questa “personalità in formazione” deve farsi carico.
Tradizionalmente in Italia, le promesse dell’impianto culturale e giuridico del diritto penale minorile sono state mantenute, in particolare per ciò che concerne i numeri (tendenzialmente bassi) della popolazione detenuta. Al 31 dicembre 2022, delle persone minorenni in carico ai servizi penali minorili, solo 381 risultavano detenuti all’interno degli Istituti Penali Minorili (IPM) a livello nazionale. Dall’anno successivo la popolazione penitenziaria minorile ha cominciato ad aumentare fino a far registrare un inedito tasso di sovraffollamento pressoché in tutti e 17 gli IPM italiani. É particolarmente rilevante come a questo incremento non corrisponda un aumento delle segnalazioni penali: i dati ufficiali più aggiornati (contenuti nel report “Criminalità minorile e gang giovanili”, realizzato dal Servizio analisi criminale della Polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza) mostrano come, proprio nel 2023, rispetto all’anno precedente, “le segnalazioni di minori, nella fascia di età compresa tra 14 e 17 anni, denunciati e/o arrestati in Italia, fanno registrare un decremento del 4,15%”.
D’altra parte proprio a fine 2023 viene emanato il Decreto-Legge 123/2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” (c.d. Decreto Caivano), che ha inaugurato una serie di misure fortemente confliggenti con l’apparato di principi sopra menzionato. Il Decreto 123/2023 interviene sul sistema della giustizia penale minorile attraverso misure varie, da un lato attraverso una estensione delle misure di prevenzione personali, agendo dunque su un terreno di pubblica sicurezza e amministrativo. Gli interventi di macroscopica rottura con l’impianto del diritto penale minorile italiano, tuttavia, si verificano proprio nell’ambito del processo penale minorile. Da una parte, infatti, vengono ampliati presupposti dell’applicazione delle misure cautelari, dall’altra si scardina la logica della Messa alla Prova, uno degli istituti cardine dell’operatività (anche in senso di abbattimento della ricaduta nel sistema penale) dell’ordinamento penale minorile.
Al momento in cui scriviamo gli istituti penali minorili sono abitati da 562 detenuti e detenute (secondo i dati dell’ultima rilevazione ministeriale, Analisi Servizi Minorili del 30/08/2025): 53 tra i 14 e i 15 anni, 275 di 16-17 anni, 194 di 18-20 anni e 40 tra i 21 e i 24 anni (è possibile, infatti, scontare la pena nel circuito penale minorile fino ai 25 anni di età). I detenuti di nazionalità italiana sono 314 (301 ragazzi e 13 ragazze) a fronte di 248 stranieri (244 ragazzi e 4 ragazze). Proprio per rispondere al dilagare del sovraffollamento minorile, dal 24 marzo 2025, è attiva una “sezione” dell’IPM di Bologna presso la Casa Circondariale per adulti “Rocco D’Amato” di Bologna, rompendo così con il principio della separazione assoluta (non solo strutturale, ma anche concettuale e culturale).
A oggi, dunque, l’aumento dei numeri delle persone minorenni detenute (e la creazione di un circuito di detenzione minorile all’interno del perimetro di un carcere degli adulti), impongono agli operatori della giustizia minorile, ai pratici del diritto e all’accademia un impegno di ricerca e un pungolo di rinnovata riflessione sul significato di quella cultura costituzionale della pena minorile che ha lavorato finora in silenzio, (ed efficacemente), ma che non possiamo (più) dare per scontata.
A cura di Sofia Ciuffoletti e Lucia Re, L’Altro diritto ODV
Per approfondimenti si veda:
Ragazzi Dentro, Giustizia minorile e Istituti penali per minorenni, Antigone
E la sezione del sito del Gruppo CRC dedicata a Minori in stato di detenzione o sottoposti a misure alternative